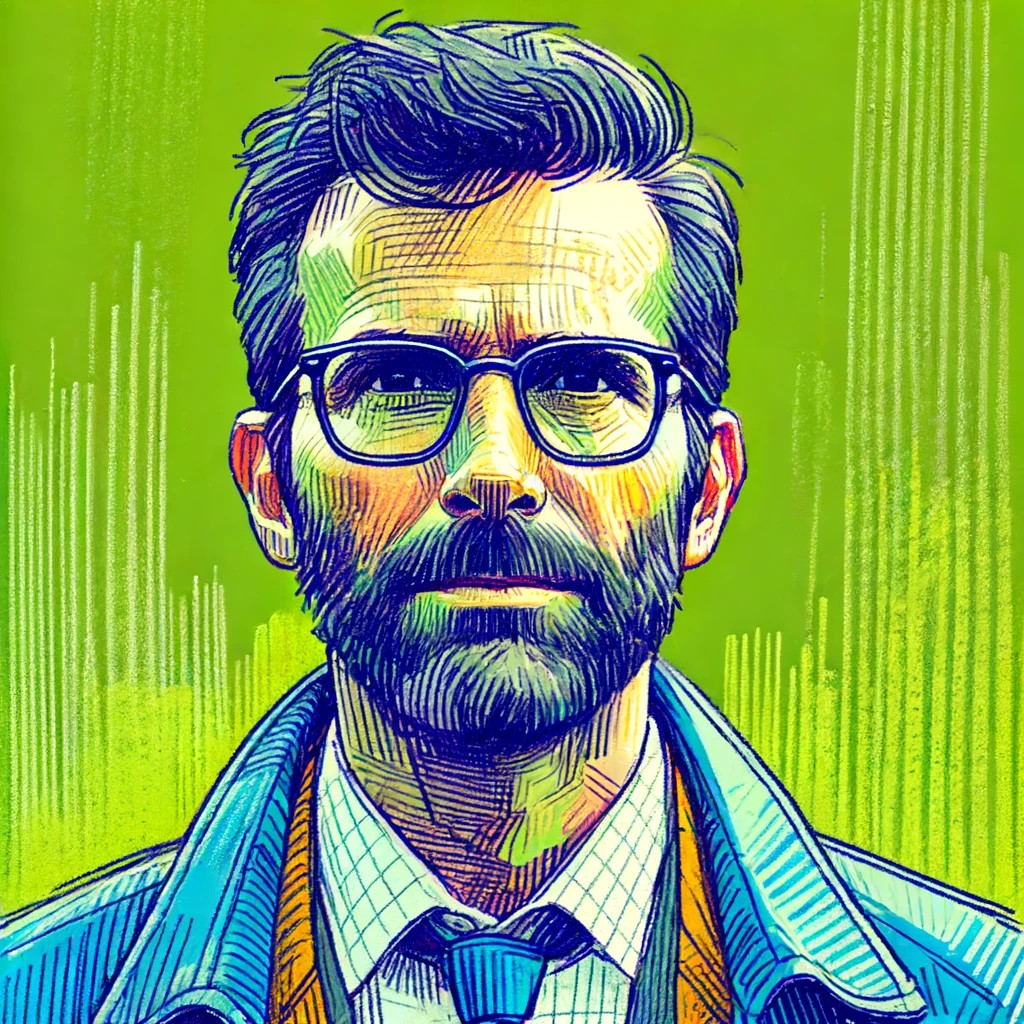
La Sociologia a portata di smartphone: nasce il canale WhatsApp di “Sociologia Italia”
In un’epoca in cui l’informazione scorre veloce e gli algoritmi dei social network spesso nascondono…
Capire la società per trasformarla: pensiero critico, cultura e futuro.
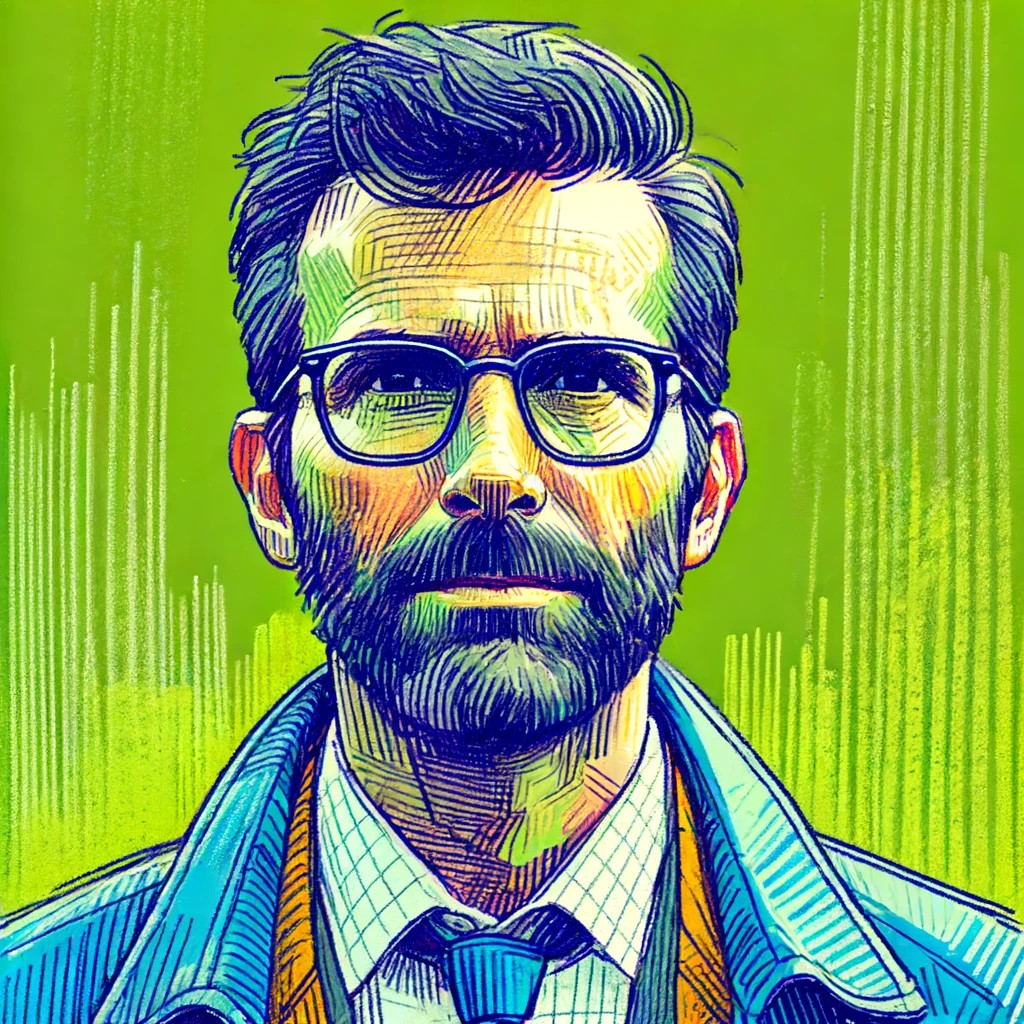
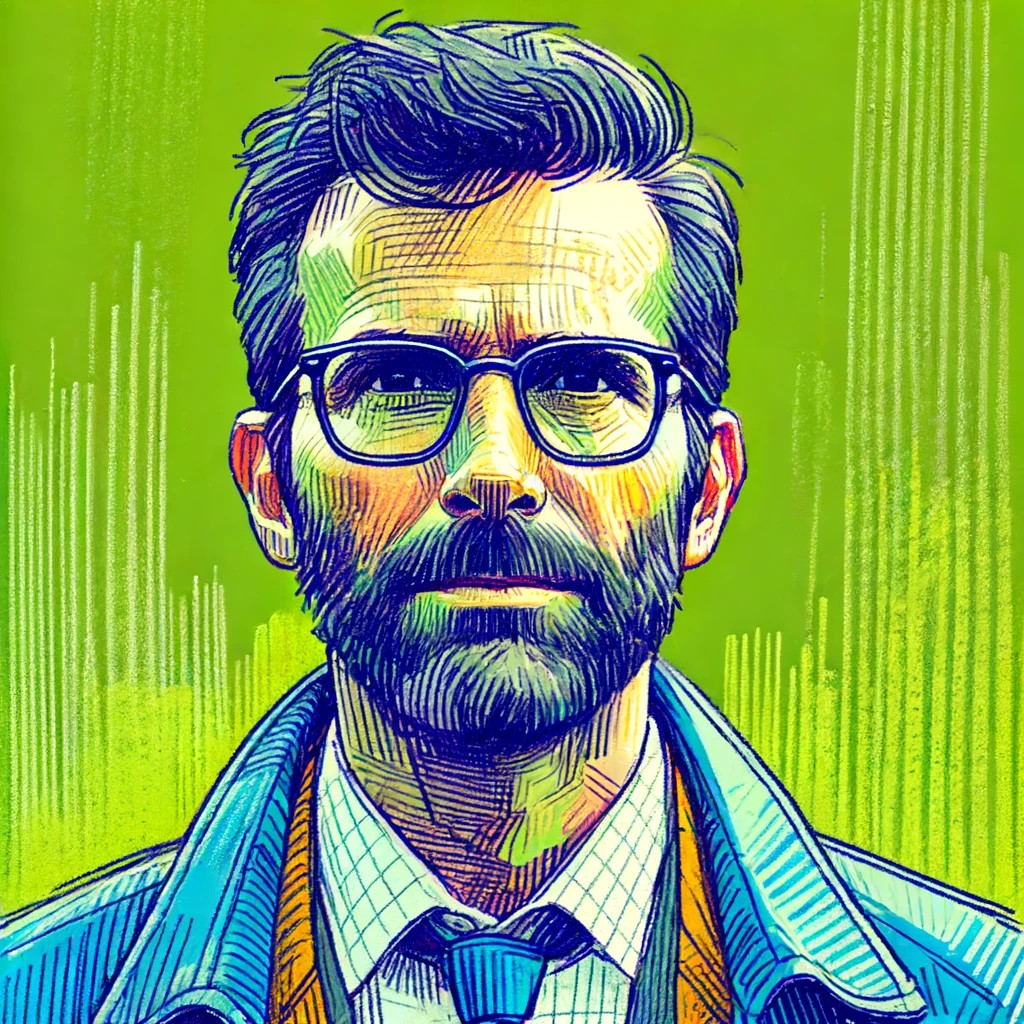
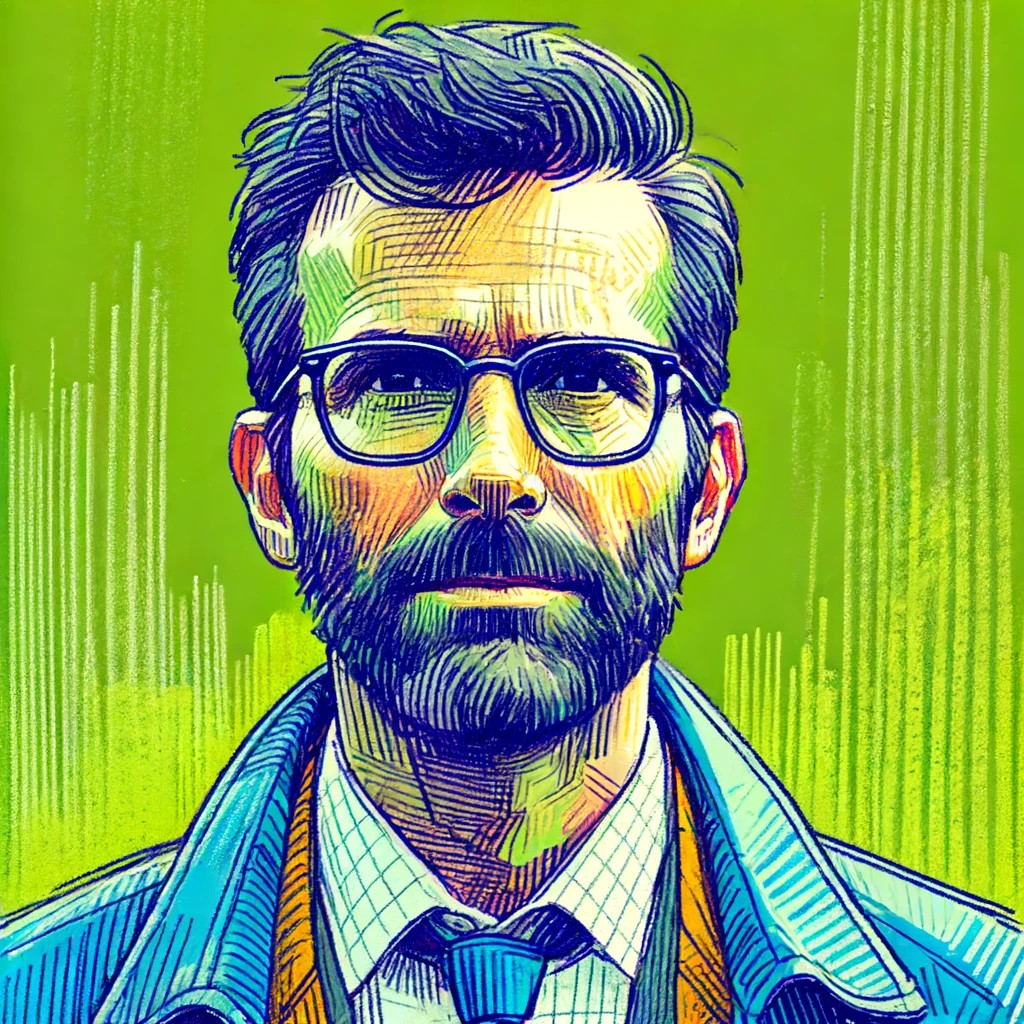
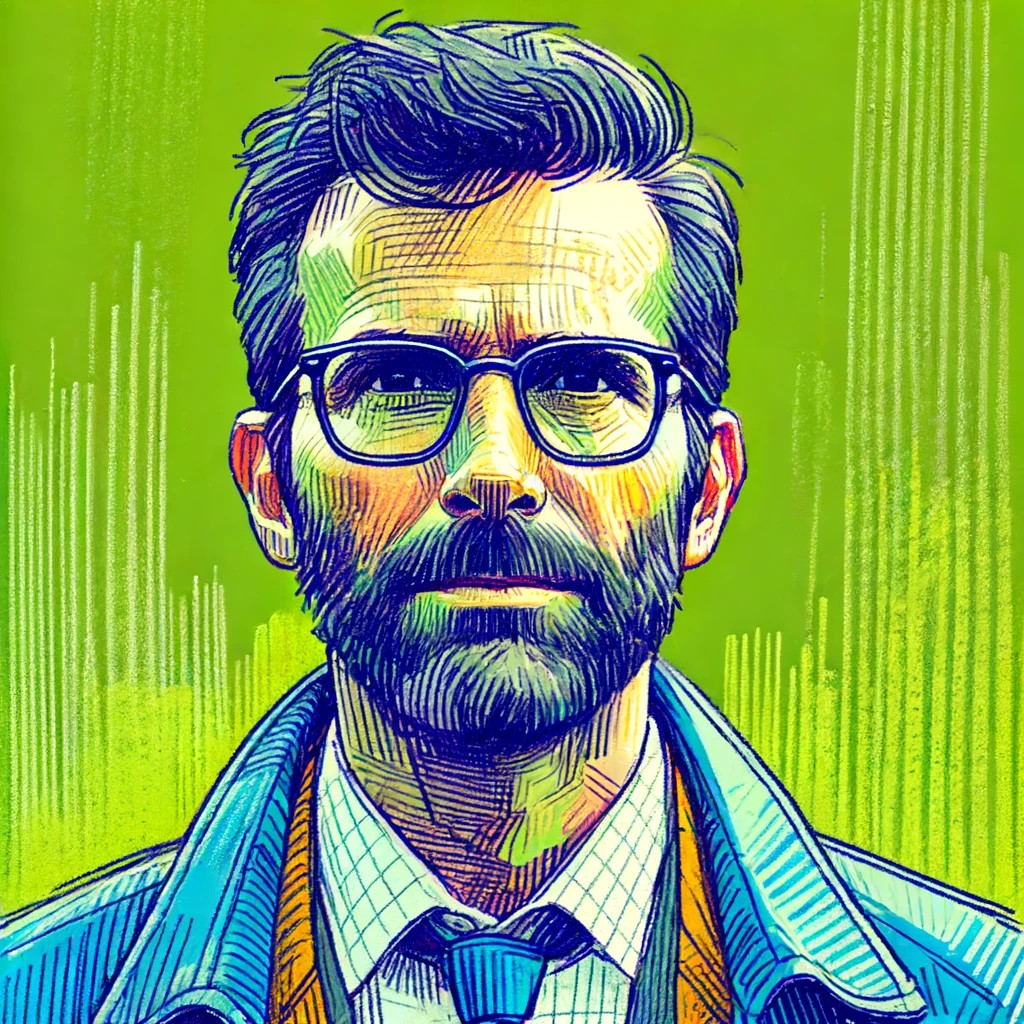
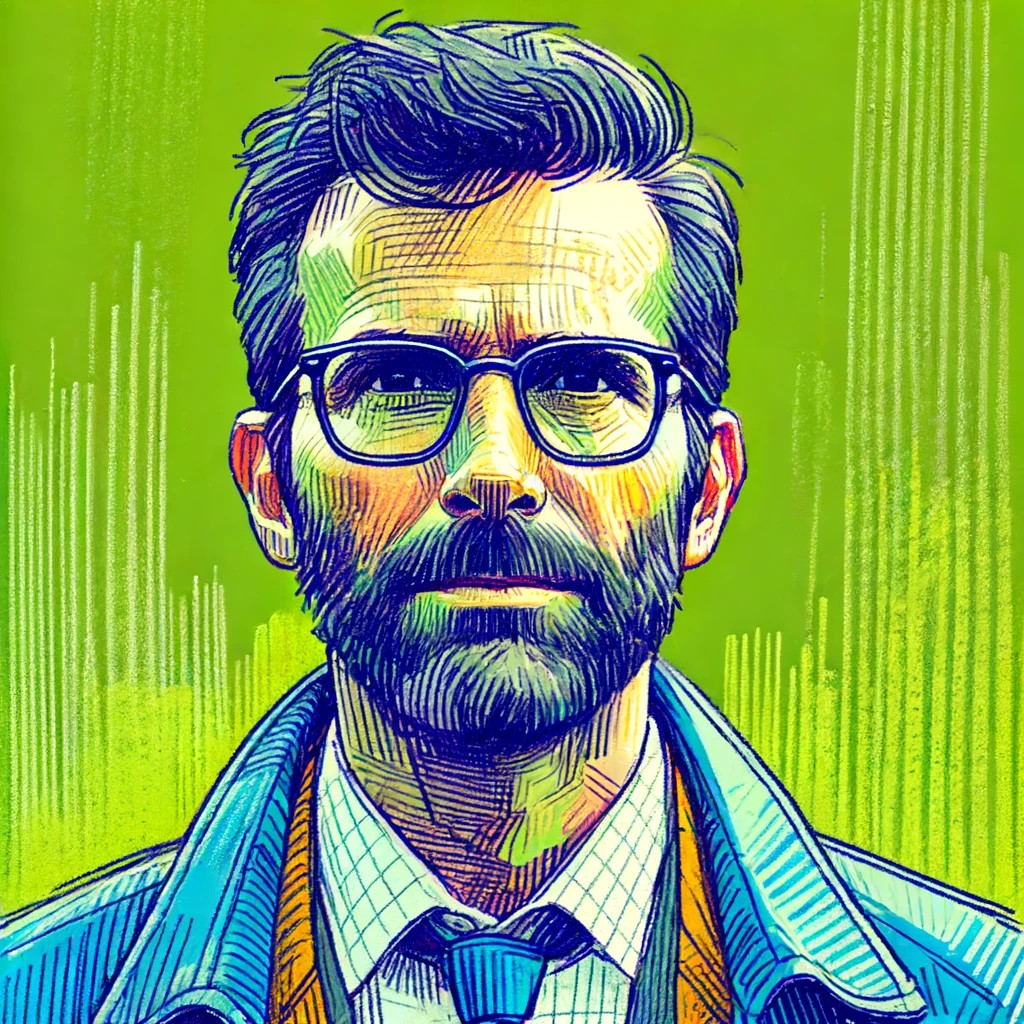
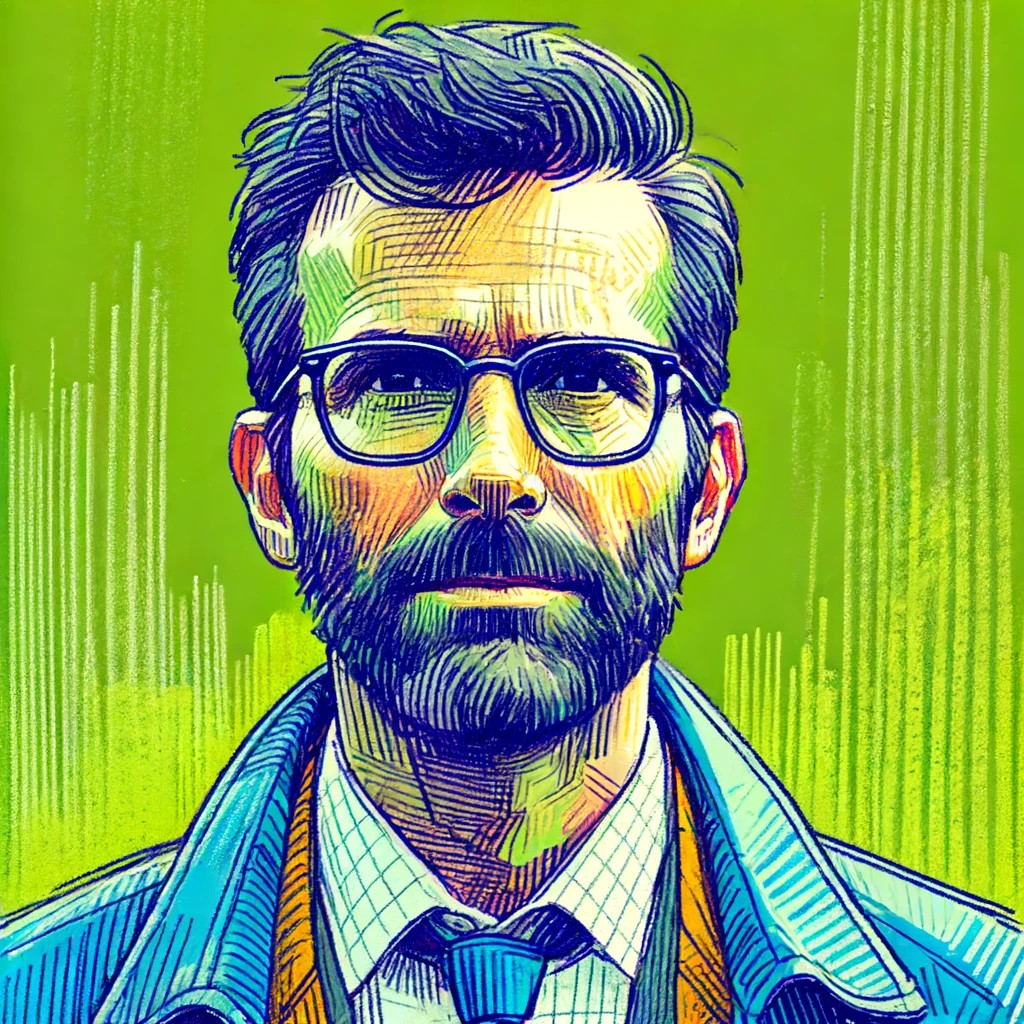
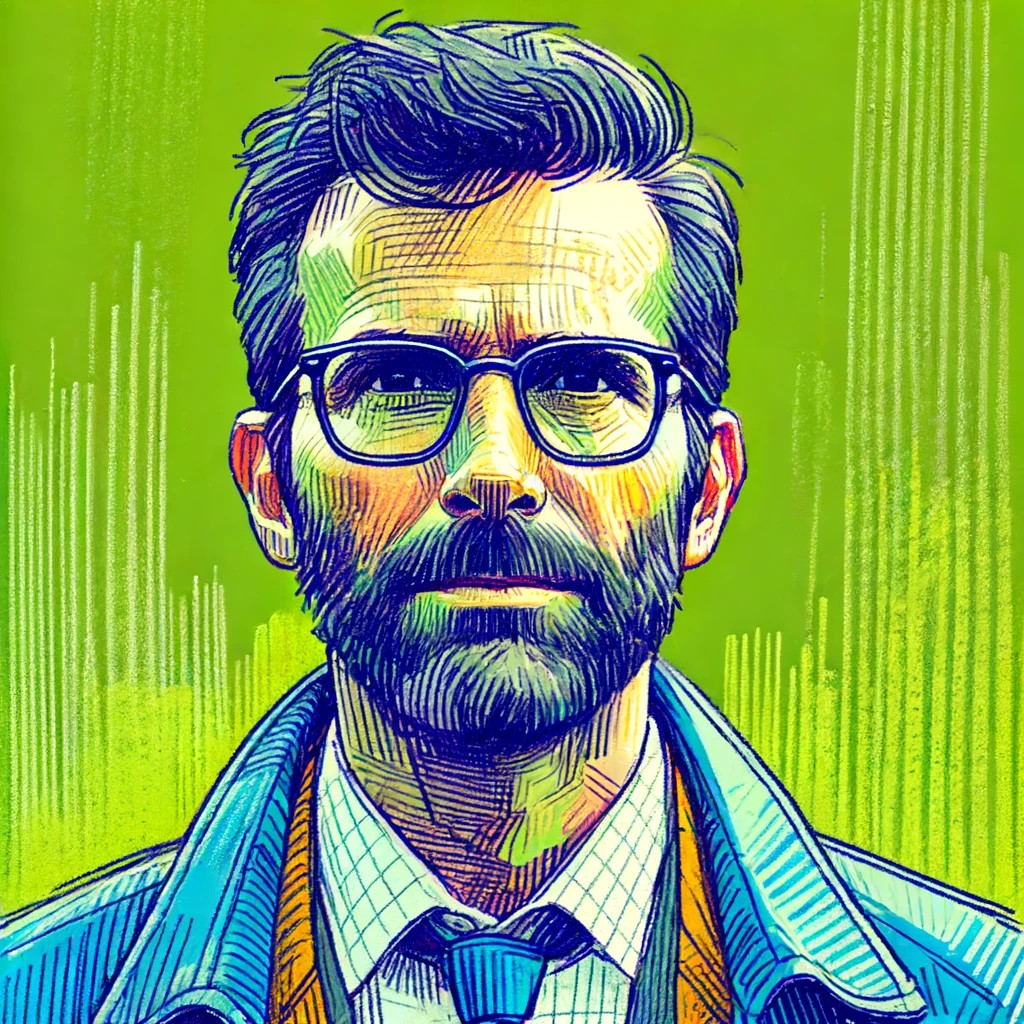
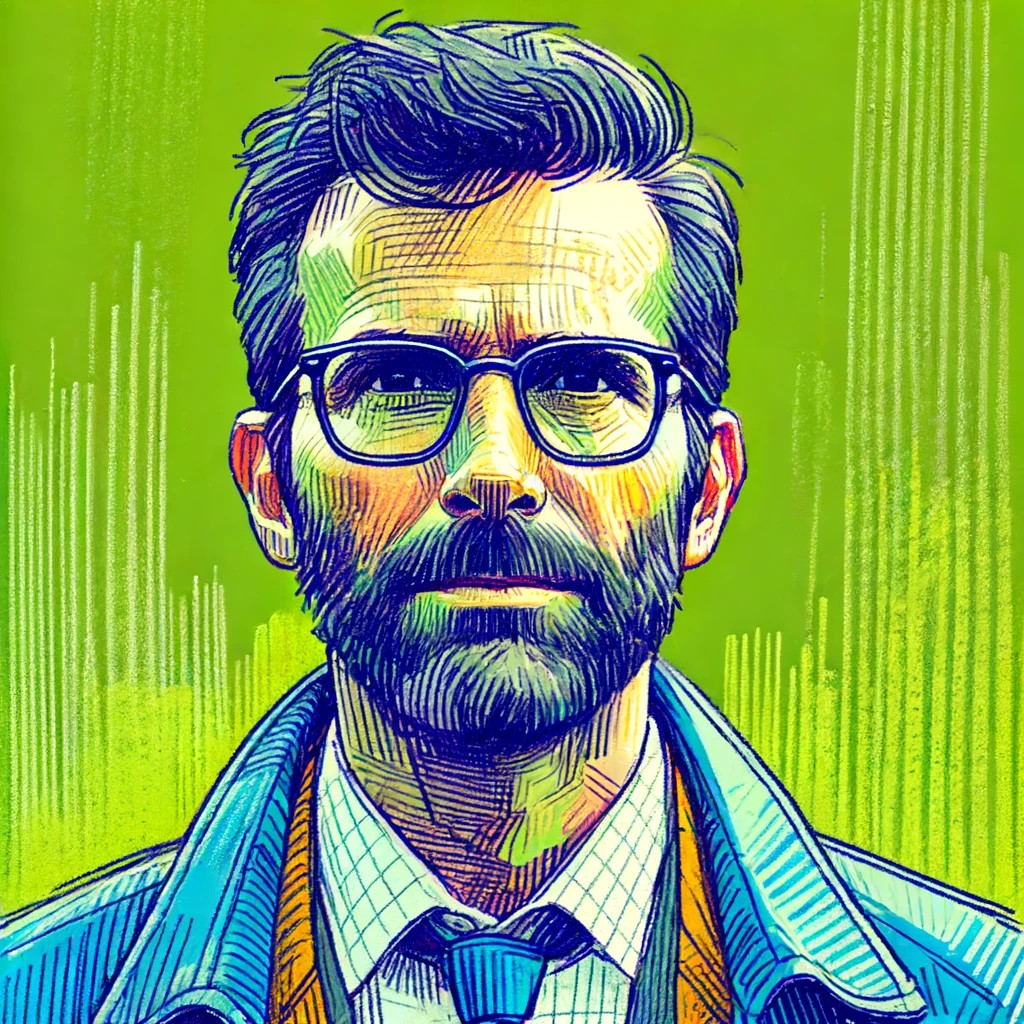
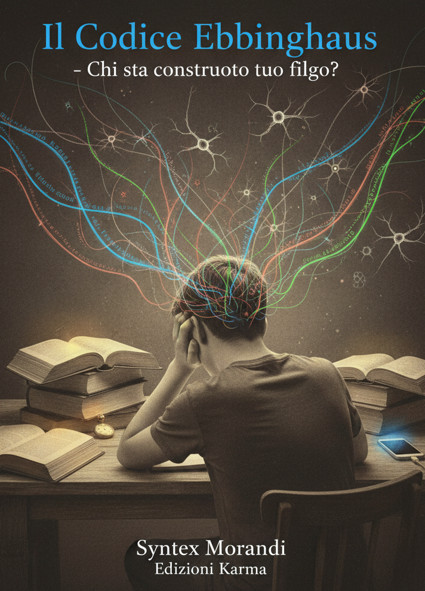
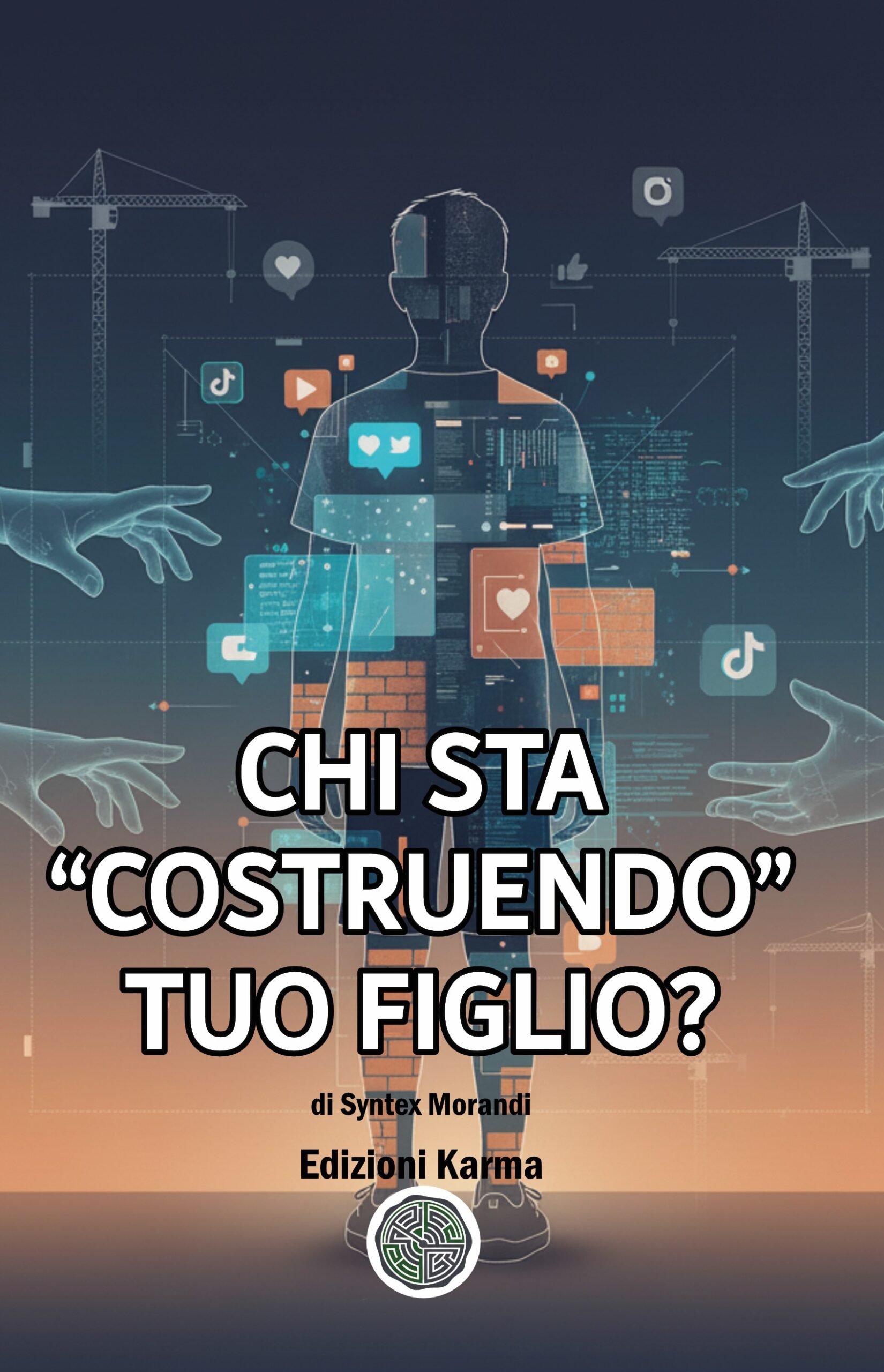
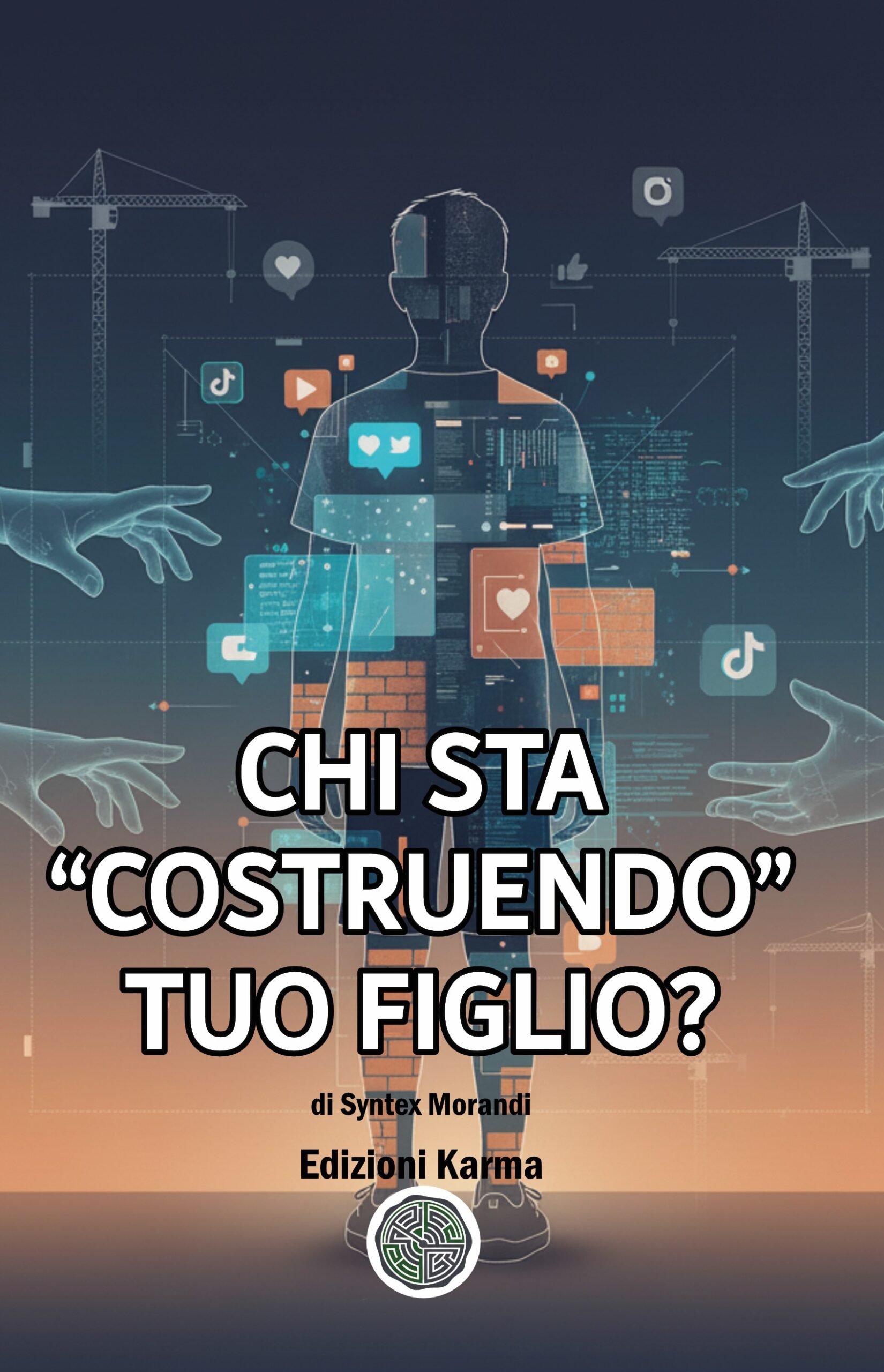
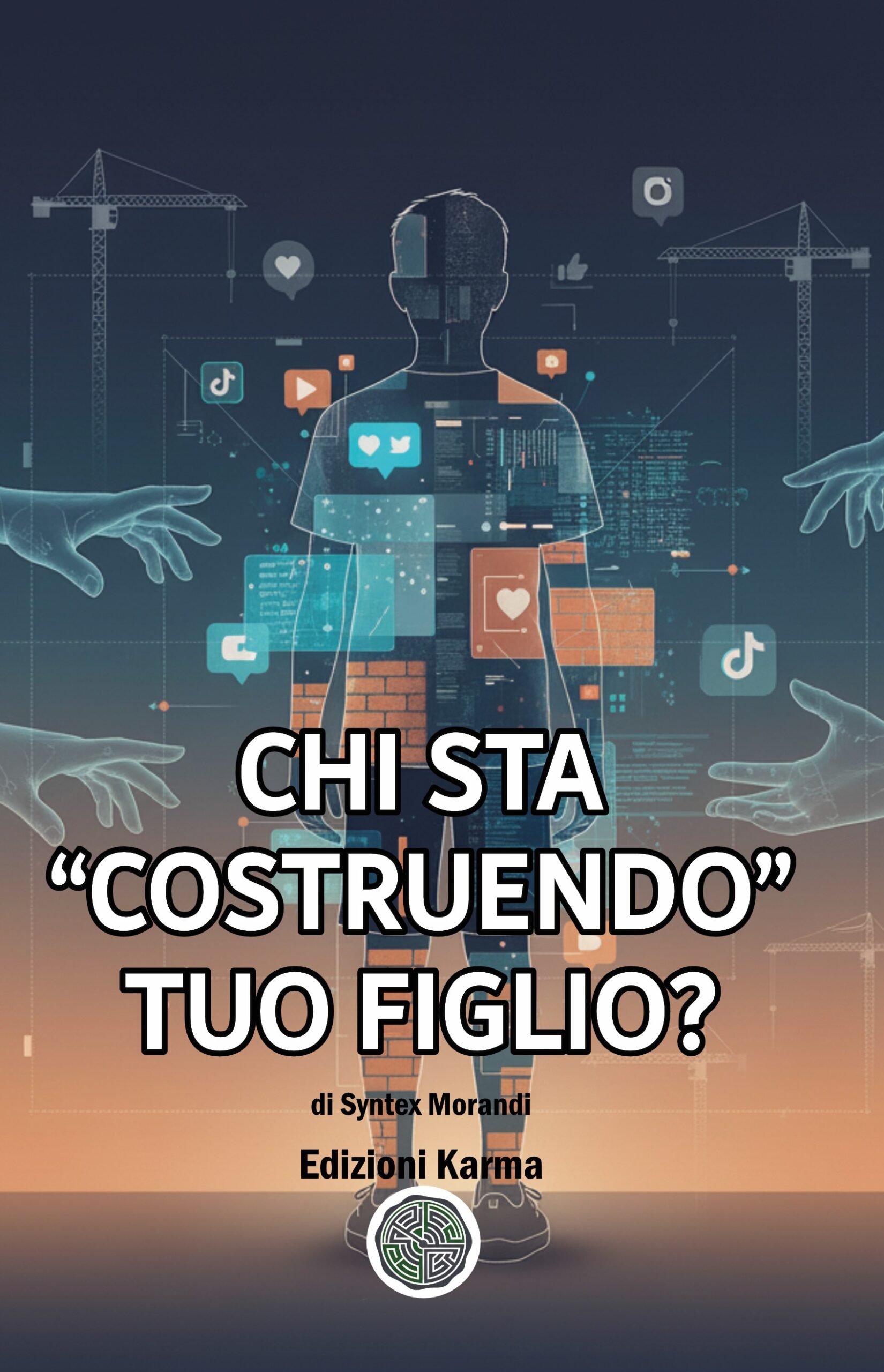
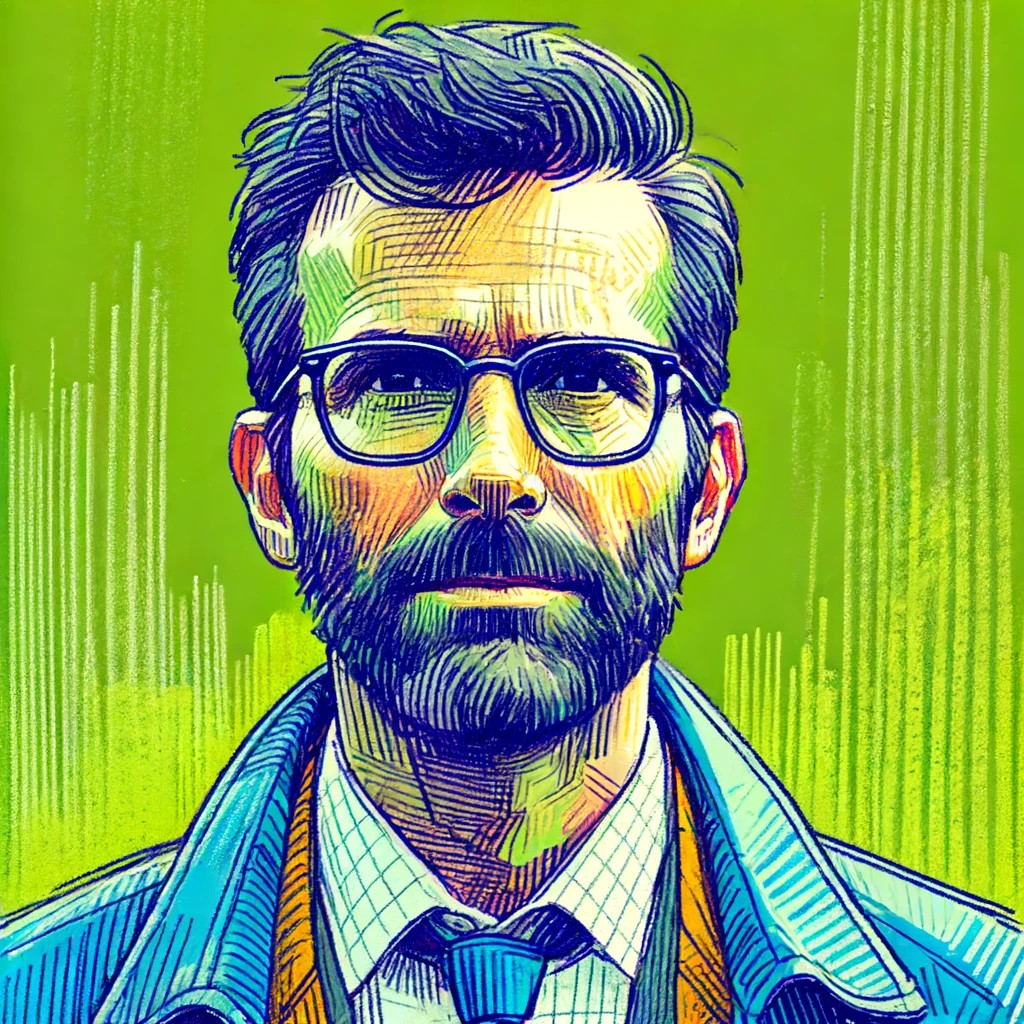
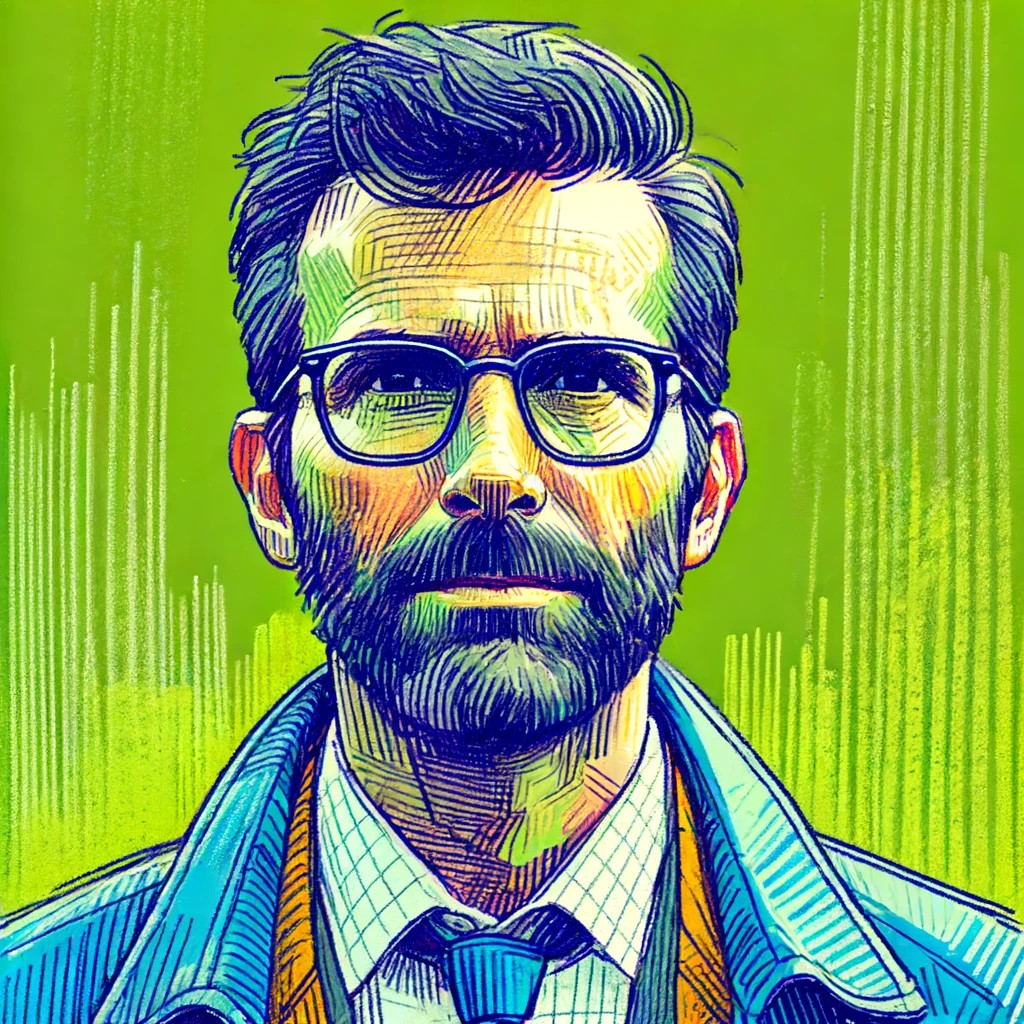
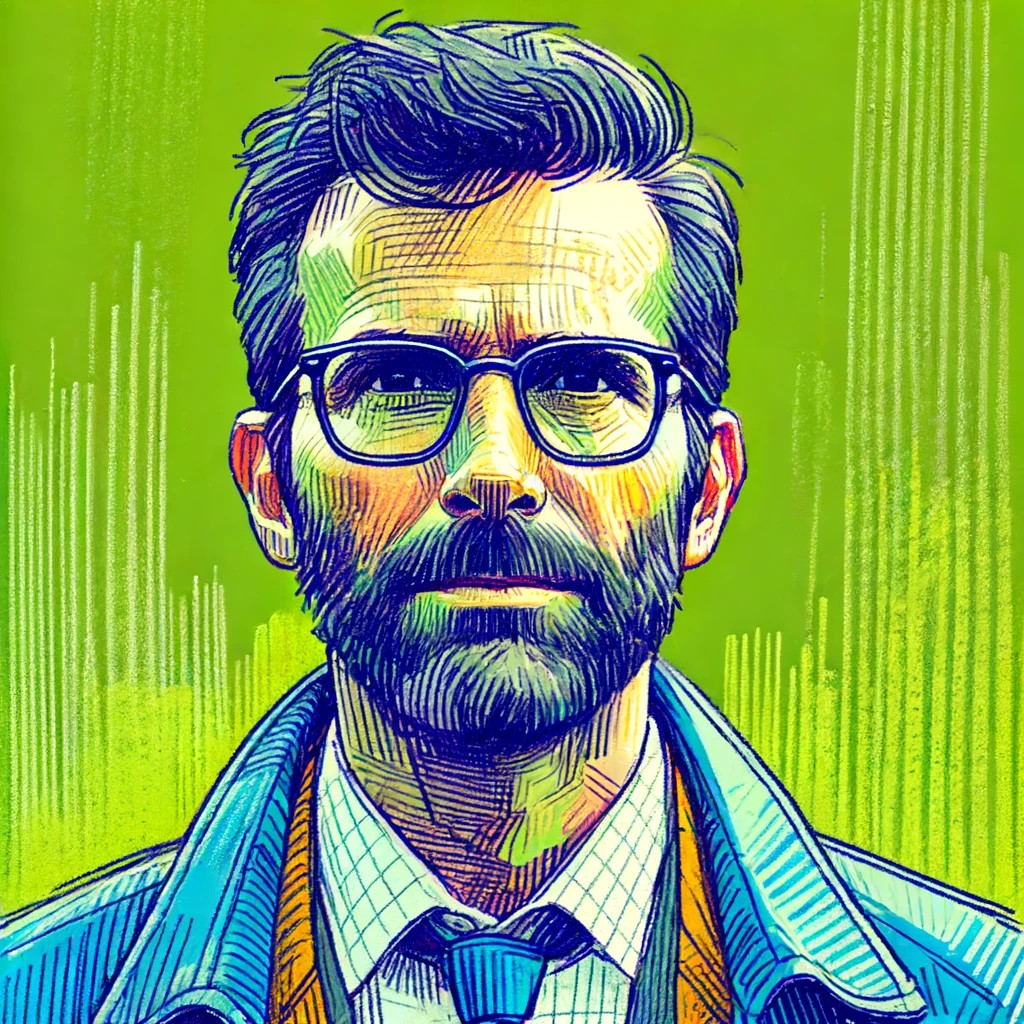
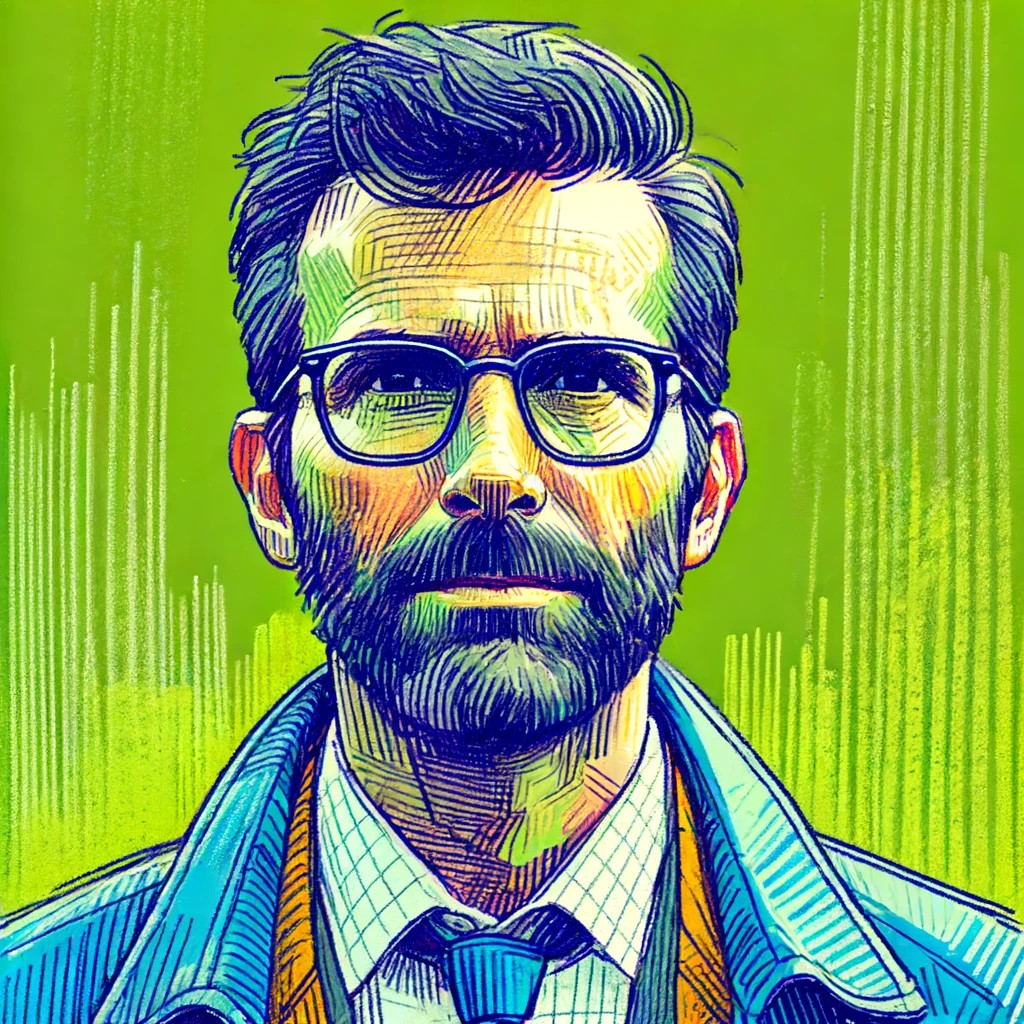
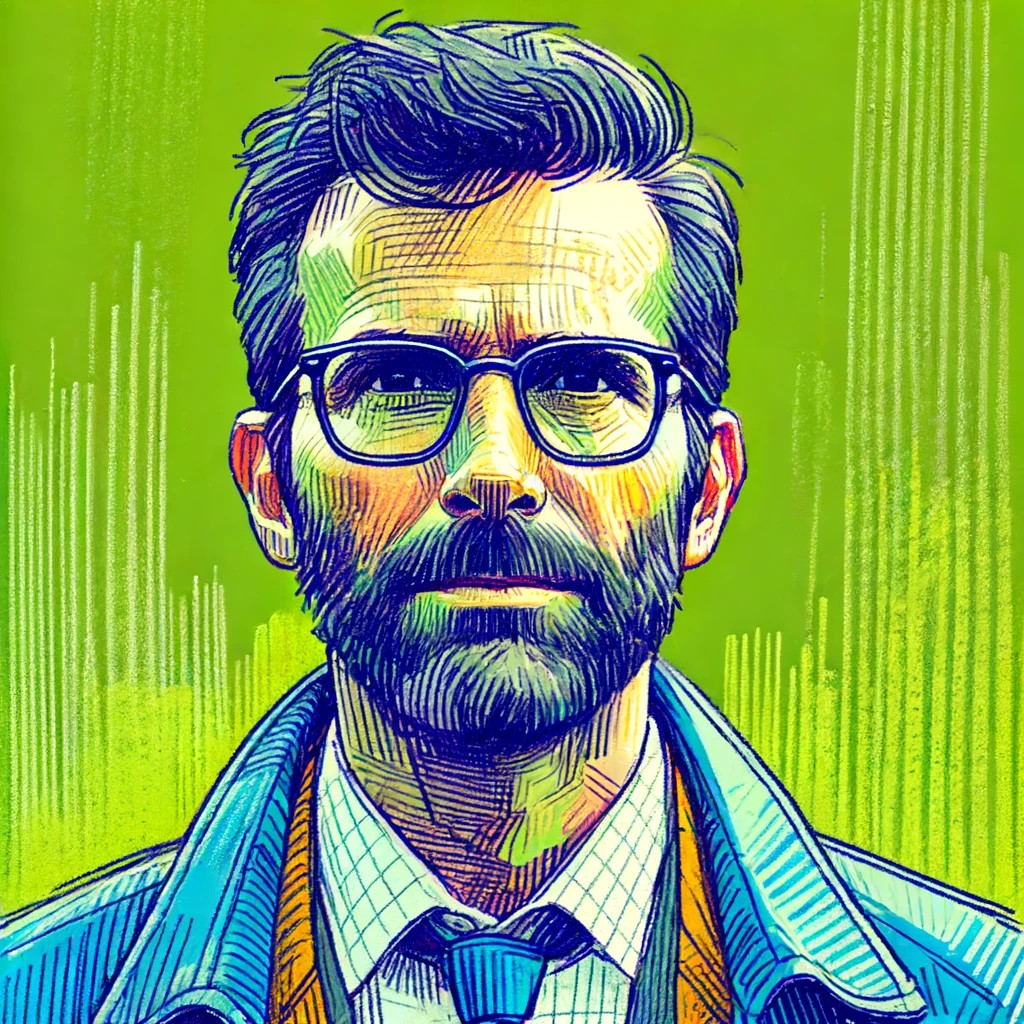
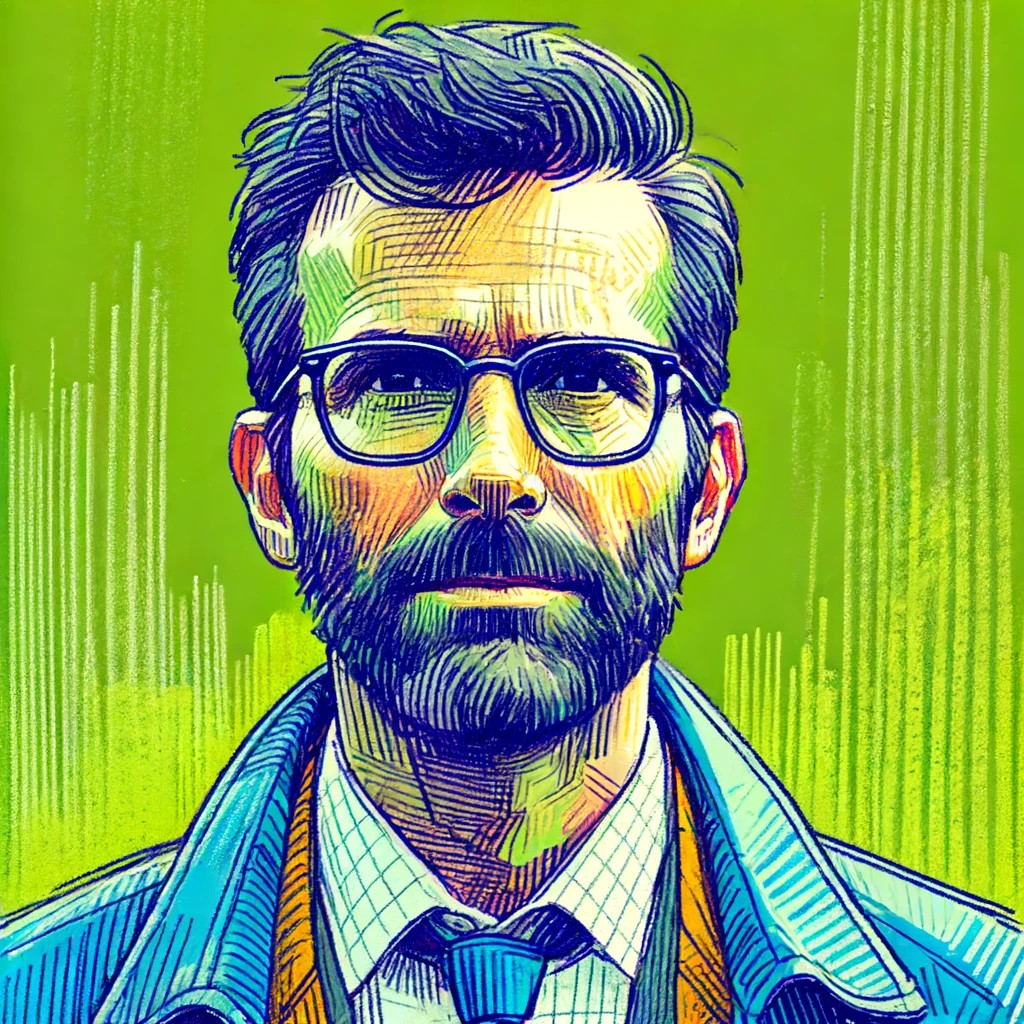
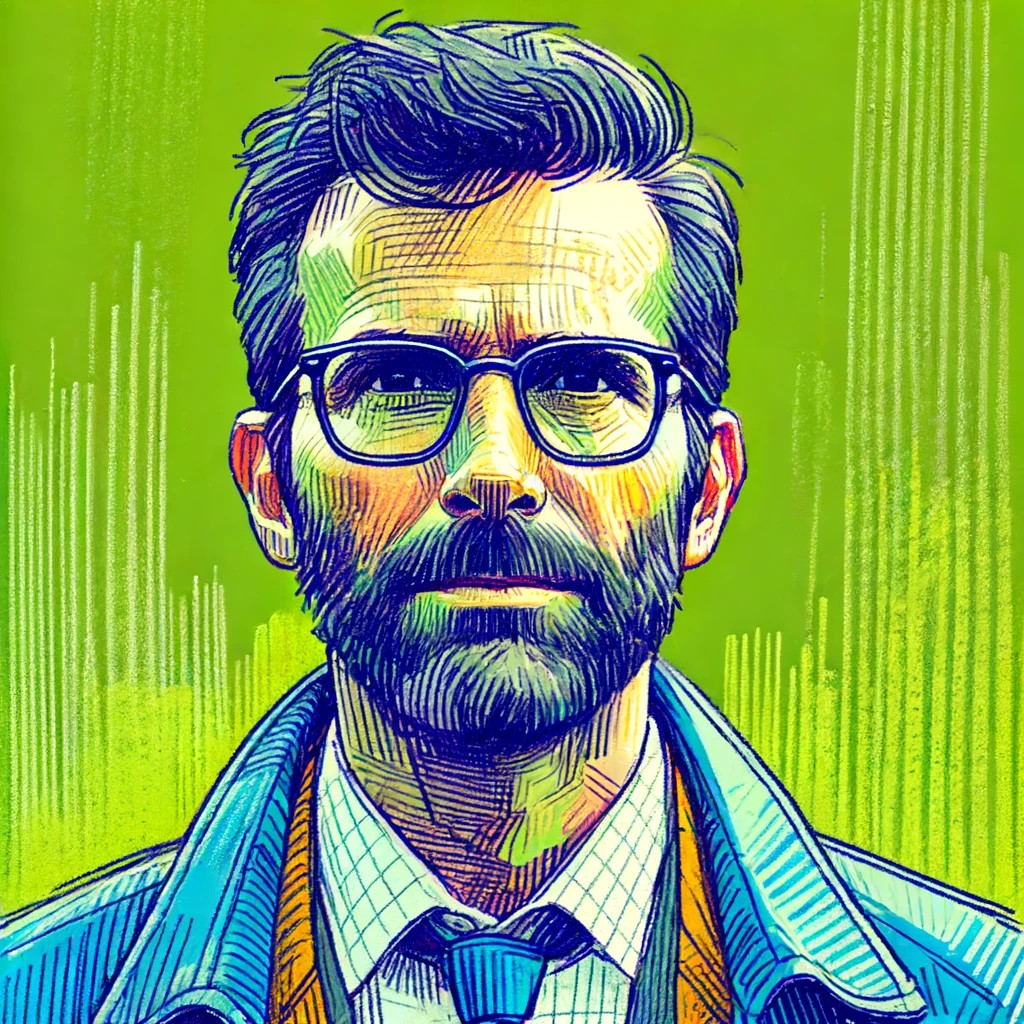
Tema Seamless Buone Ricette, sviluppato da Altervista
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario